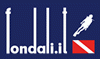Gli spazi d’aria del corpo umano che subiscono gli effetti della pressione, durante un’immersione con l’autorespiratore, sono orecchie e seni paranasali.
L’apparato uditivo si suddivide in tre zone: orecchio esterno, interno e medio.

Il primo, costituito dal padiglione auricolare e condotto uditivo, è costantemente in contatto con l’ambiente esterno, per cui, si troverà sempre in equilibrio con lo stesso.
Nell’orecchio interno si trovano la chiocciola, o coclea, e i canali vestibolari. Questi, sono immersi nella perilinfa, un liquido che rende la zona incomprimibile. Per cui non influenzabile dalla pressione esterna.
Quello che causa fastidio e dolore, è la compressione dell’aria contenuta nell’orecchio medio, o cassa timpanica. Questa variazione di volume è dovuta all’introflessione della membrana timpanica.
All’interno dell’orecchio medio si trova la catena di ossicini: martello incudine e staffa. Il primo è connesso al timpano, che separa la cassa timpanica dall’esterno. L’ultimo, la staffa, è unito alla finestra ovale, sulla parete labirintica. Quest’ultima separa l’orecchio medio da quello interno.
L’orecchio medio è in comunicazione col rinofaringe tramite la tuba di eustachio. Che, in condizioni di riposo, è un canale virtuale. Le sue pareti, infatti, sono collassate e si aprono o con meccanismi fisiologici: deglutizione, masticazione o sbadiglio. O con meccanismi indotti, come variazioni pressorie o insufflazioni. Questi ultimi prendono il nome di manovre di compensazione.
La più diffusa di queste manovre è quella ideata dal celebre anatomista Antonio Valsalva:
chiudendo narici e bocca, ed eseguendo uno sforzo espiratorio, si crea un aumento della pressione dell’aria intratoracica, che non avendo altre vie di fuga, risale verso il timpano attraverso le tube di eustachio.
 La seconda tecnica è quella messa a punto da uno dei fondatori della subacquea italiana, Duilio Marcante, ed il pioniere della medicina iperbarica, il professor Giorgio Odaglia.
La seconda tecnica è quella messa a punto da uno dei fondatori della subacquea italiana, Duilio Marcante, ed il pioniere della medicina iperbarica, il professor Giorgio Odaglia.
La manovra di Marcante-Odaglia, conosciuta nel mondo come manovra di Frenzel, non è di semplice esecuzione. Si pratica, sempre con narici chiuse, isolando completamente la regione del rinofaringe dalle restanti cavità aeree: spingendo verso l’alto il palato molle, si provoca una riduzione del suo spazio, facendo aumentare la pressione dell’aria contenutavi. Il movimento della lingua, azionata come un pistone verso l’alto, fa contrarre i muscoli faringei che, prossimi agli orifizi delle tube di eustachio, ne favoriscono l’apertura e quindi il passaggio dell’aria a pressione verso l’orecchio.
Nonostante la difficoltà di esecuzione, questa risulta meno traumatica per il timpano e non richiede l’intervento di sovrapressione polmonare, dando una pressione anche superiore a quella che si ottiene con la pratica della Valsalva.
Esistono anche altre tecniche di compensazione, che, tuttavia, dipendono da predisposizioni personali. In alcuni soggetti, ad esempio, il semplice movimento mandibolare o di deglutizione, stimola l’apertura degli orifizi delle tube, mettendo l’orecchio in collegamento con l’aria contenuta negli altri spazi aerei, già a pressione ambiente, ristabilendone l’equilibrio pressorio.
La mancata compensazione dell’orecchio medio può portare ad un barotrauma, come la rottura della membrana timpanica.
Bisogna cominciare a compensare già dai primi metri di discesa, anticipando il fastidio.
Un ritardo di esecuzione, o la presenza di muco nelle vie respiratorie che ostruisce gli orifizi delle tube di eustachio, comprometterebbero la corretta esecuzione di una delle manovre sopradescritte.
Ad esempio, quella di Valsalva, se fatta in modo forzato, potrebbe causare la rottura della finestra rotonda: il timpano, introflesso dalla pressione esterna, spingendo sulla catena degli ossicini, fa introflettere la finestra ovale, che causerà un aumento della pressione della perilinfa. Queste variazioni di pressione vengono equilibrate dall’estroflessione della finestra rotonda, situata anch’essa sulla parete labirintica.
Bisogna precisare che il modo forzato dell’esecuzione, causa anche un ritorno di sangue ai polmoni, inibendo il flusso nelle vene principali che tornano al cuore, che, cominciando a gonfiarsi, causano un aumento della pressione venosa. Di conseguenza si avrà un ulteriore aumento della pressione dei liquidi cerebrali, tra cui, la già citata perilinfa. Che, esercitando un’eccessiva pressione, potrebbe causare la rottura della finestra rotonda, fuoriuscendo dall’orecchio interno.
Le conseguenze sono perdita temporanea dell’udito e vertigini.
Non bisogna mai trovarsi nelle condizioni di dover forzare la manovra di compensazione.
In presenza di muco, è sconsigliato l’utilizzo di decongestionanti: solitamente, nella composizione del farmaco vi è l’efedrina, una sostanza termolabile. La bassa temperatura dell’acqua potrebbe ridurne l’effetto in termini di tempo. Quindi, durante l’immersione, si dovrebbe fronteggiare una nuova formazione di muco, che in risalita, tornerebbe ad ostruire le vie di fuga dell’aria in sovrapressione nell’orecchio medio, rendendone difficile la fuoriuscita, che in situazioni normali, fuoriesce automaticamente.
Il tali casi, si verrebbe a manifestare il fenomeno del blocco inverso, che, solitamente, causa vertigini. Spesso di notevole intensità.
 Come scritto all’inizio, anche i seni paranasali subiscono gli effetti della pressione.
Come scritto all’inizio, anche i seni paranasali subiscono gli effetti della pressione.
Sono delle piccole cavità piene d’aria, posizionate dietro e sotto gli occhi e il naso. Hanno funzione di alleggerimento del cranio, cassa di risonanza per i suoni, ed isolamento e protezione dalle basse temperature. Si dividono in sfenoidali, frontali, etmoidi e mascellari.
Si trovano a diretto contatto con le altre vie respiratorie e, normalmente, la pressione dell’aria al loro interno si compensa automaticamente. Invece, in caso di raffreddore, le vie d’ingresso di queste cavità sono ostruite, rendendone impossibile la compensazione.
Infine, fattore non trascurabile e poco menzionato, le variazioni di pressione possono influire anche su piccole sacche d’aria create da otturazioni odontostomatologiche mal eseguite. Causando dolore.
© M.G.
Articoli correlati:
La pressione sott’acqua
Effetti della pressione sugli spazi d’aria di un sub in immersione
Pubblicato su Cose da sub
Tag: Cose da sub, Effetti della pressione sott'acqua, Fisiologia dell'immersione, Manovre di compensazione